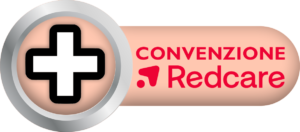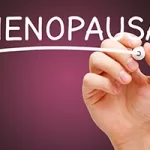Un aiuto per i figli con disabilità

La legge del dopo di noi: quando manca il sostegno famigliare
Un figlio con disabilità, grave disabilità, sofferenza indicibile per i genitori. Ma anche gioia di vederlo crescere insieme, in un nucleo famigliare che lo supporta, lo cura, lo aiuta. E, naturalmente, viceversa.
Nei genitori tuttavia, col passare degli anni, si fa via via più intensa, e con angoscia, la domanda: cosa succederà quando noi non ci saremo più?
Su questa scia è nata la legge 212 del 22 giugno 2016, ovvero “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Una legge ribattezza del “dopo di noi” o più esattamente del “durante e dopo di noi”, come sottolinea Roberto Speziale, presidente di Anffas, Associazione Nazionale famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi nel neurosviluppo.
La legge del dopo di noi: cosa c’era prima
La legge del “durante e dopo di noi” nasce per tutte quelle persone con gravissima disabilità e con genitori divenuti molto anziani e non più in grado di prendersene cura presso casa loro. Ma anche per assenza di altri riferimenti famigliari.
Impossibilitate, insomma, a continuare a vivere a casa loro.
“Prima della legge”, spiega il presidente Speziale, “c’era un’unica soluzione: l’istituzionalizzazione, cioè il ricovero in una struttura sanitaria residenziale”.
I diritti delle persone con disabilità
In questo scenario, va ricordato l’articolo 19 della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: sancisce il diritto di queste persone a vivere in modo indipendente e inclusivo nella comunità. Tale articolo, in Italia, viene prima recepito con la legge 18 del 2009, poi con la legge 212 del durante e dopo di noi del 2016.
Insomma, l’Onu e poi le normative stabiliscono che le persone con disabilità possono scegliere dove, come e con chi vivere. Soprattutto non devono essere istituzionalizzate.
Commenta Roberto Speziale. “La 212 è una legge di iniziativa parlamentare, votata con una convergenza trasversale, prima alla Camera poi al Senato, all’unanimità. E con grande coinvolgimento delle associazioni e delle federazioni tra cui noi come Anffas”.
Frutto della larga collaborazione, la prima istruzione riguarda la casa: non possano coabitare più di 5 persone con disabilità. L’intento è infatti quello di avere una situazione alloggiativa che riproduca al massimo la casa di origine. Nei decreti attuativi della legge 112 si dice bene che le persone con disabilità devono vivere o in una stanza a letto singolo o massimo a 2 letti, con possibilità di poter avere i propri mobili, le proprie suppellettili. Non una struttura ospedaliera, quindi, ma una vera e propria casa.
La legge punta a un progetto di vita
E come si ottiene questo? Il presidente Speziale è chiaro: “Si fa attraverso un progetto di vita, garantito appunto dalla legge 112 e che parte da una valutazione multidimensionale. Cosa significa? Più soggetti, tanto di parte pubblica tanto da parte della persona, si debbono mettere insieme, valutare ciò che è meglio per la persona stessa.
Il progetto di vita che la legge 112 del dopo di noi garantisce, o almeno dovrebbe garantire, è che la scelta da effettuare corrisponda ai desideri, alle esigenze, alle aspettative della persona con disabilità. Una condizione adottata che sia esattamente la migliore per la persona. E questo non si improvvisa”.
La legge del dopo di noi è decisamente “durante noi”
Proprio parlando della legge 112, la si definisce ‘durante e dopo di noi’. “Non è un caso”, puntualizza il presidente, “perché bisogna iniziare per tempo. In che modo? La legge prevede alcune misure.
La prima”, continua, “è quella del potenziamento delle autonomie.
La persona con disabilità che deve andare a vivere in un appartamento, in base alla complessità del suo stato, può fare alcune cose e altre che “vuole” fare ma magari non è capace. Rifarsi il letto, poter assolvere in autonomia le proprie funzioni igieniche, prepararsi il cibo, accudire la casa… queste cose vanno insegnate. Alcuni possono arrivare a livelli molto alti, altri no. Dipende”.
La legge del dopo di noi: la famiglia si deve preparare
Un’altra misura prevista dalla legge del durante e dopo di noi, è lavorare sul progressivo distacco dalla famiglia di origine. Esattamente la fase del ‘durante noi’. Ma tale distacco riguarda ovviamente la famiglia stessa, la madre, il padre, i congiunti vicini, devono cominciare a “lasciar andare” il proprio figlio, la propria figlia.
Prima con qualche pomeriggio di allontanamento nei weekend, ad esempio, poi passando a periodi più lunghi. Un periodo di adattamento sia per la persona con disabilità sia per i genitori che saranno un po’ più tranquilli sapendo della destinazione del loro caro.
La legge e l’assistenza che serve
Nella soluzione abitativa della legge del dopo di noi sono previste figure di assistenza in base ai bisogni e al tipo di sostegno necessario per le persone con disabilità. E vengono individuate quando si disegna il progetto di vita.
Inoltre, la legge precisa come deve essere la “nuova” casa, qualsiasi tipologia ma non che sia isolata. Deve essere inclusiva, permettere alle persone con disabilità di far parte dell’ambiente.
La legge del dopo di noi: quando interviene lo stato
La legge 112 del dopo di noi mette a disposizione risorse finanziarie per poter acquistare, ristrutturare o affittare un immobile. Utile naturalmente per chi non ha in origine patrimoni cui attingere.
Chi acquista può essere un gruppo di famiglie ma di solito è un’associazione o una fondazione che promuove l’iniziativa.
La legge ha un fondo nazionale di 70 milioni di euro all’anno. In 9 anni ci sono stati circa 630 milioni di euro finanziati dallo Stato per poter sostenere la legge 112.
Purtroppo in molte regioni di queste risorse ne sono state spese molto poche. Per cui non sono riuscite a dare attuazione concreta alla legge del dopo di noi.
Le Regioni più virtuose sono Lombardia, Emilia Romagna, Toscana.
La legge e la figura del trustee
Nella legge del dopo di noi è stata introdotta la figura del Trustee, ancora poco utilizzata. Il termine deriva da trust, fiducia, e trustee è il fiduciario, quindi qualcuno che gestisce i patrimoni della persona con disabilità. Può essere sia una persona fisica sia una società fiduciaria. Naturalmente questa condizione esiste quando i patrimoni sono di una certa consistenza, anche perché l’istituzione del Trustee ha costi notevoli.
Il Trustee deve rispettare le indicazioni che la famiglia stabilisce nei confronti del congiunto disabile. Diventa proprietario dei beni che gli sono stati affidati, ma con un effetto segregativo. Pertanto non può disporne a piacimento, ma solo per l’interesse del destinatario.
In un tavolo tecnico ministeriale di cui fa parte anche Anffas, si sta tendando di introdurre i patti fiduciari, che hanno una matrice normativa italiana e potrebbero avere meno difficoltà interpretative. Al momento però tale strumento si può usare solo per le persone interdette mentalmente, incapaci di curare i propri interessi.
Il futuro della legge del dopo di noi
La legge del dopo di noi è buona, dicono gli addetti ai lavori, come il presidente Speziale. Ma con qualche aspetto da correggere.
“Intanto la possibilità di ampliare i destinatari della legge 112 anche a chi non ha disabilità gravi come previsto”.
Per Speziale è poi fondamentale che attraverso la legge si possano concretizzare esperienze di cohousing. “Ovvero dare la possibilità di realizzare convivenze tra persone con disabilità e persone senza disabilità. Prendiamo uno studente universitario fuori sede che rientrando dalle lezioni possa convivere con due-tre persone con disabilità, prendendosene cura. Per lui sarebbe un’esperienza di vita incredibile, per le persone con disabilità un’esistenza davvero in chiave inclusiva”.
Il presidente Speziale ricorda infine un ulteriore aspetto che va modificato. Riguarda le risorse economiche: la legge è legata a bandi annuali. Questo potrebbe interrompere il flusso dei fondi e il conseguente progetto di vita che porta la persona con disabilità fuori casa. La prospettiva, nel caso una casa non ci sia più, è sempre la stessa: l’istituzionalizzazione.

>>> Per saperne di più visita il sito Anffas
Take Home Message
La “legge del dopo di noi” (legge 212/2016), Come funziona? Cosa si deve fare per farla attivare? La nostra Cinzia D’Agostino ne ha parlato con Roberto Speziale, presidente di Anffas, Associazione Nazionale famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi nel neurosviluppo