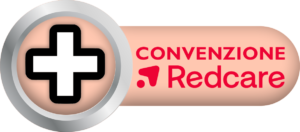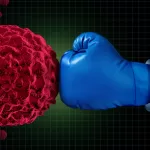La medicina nel medioevo
La medicina nel medioevo
Il collasso dell’impero romano d’occidente determinò il totale sconvolgimento, la frantumazione e la dispersione della civiltà che, nel corso di tanti secoli dalla fondazione di Roma, una così potente e vitale autorità era stata capace di sviluppare e diffondere in modo unitario in tutta l’Europa e parte dell’Asia e dell’Africa, attraverso una cultura che, a buon diritto, può essere considerata la più ampia ed evoluta fino a quel momento raggiunta dall’umanità.
Come tutti sappiamo, poi, per altri mille anni ancora, rimase in piedi solo l’impero romano d’oriente, mantenendo in Italia fino al 751 (invasione dei Longobardi) un avamposto della cultura romano-bizantina (Ravenna), ormai divenuta diversa da quella classica e fortemente influenzata dal pensiero cristiano.
Il cristianesimo, infatti, aveva soppiantato e scardinato ogni altro credo religioso ed era divenuto il solo culto ammesso dalle autorità del momento. Era riuscito a mettere salde radici nello spirito cultuale della gente comune, che però era divenuta in poche generazioni quasi totalmente analfabeta e alle prese con condizioni di vita estremamente precarie. Inoltre era riuscito a penetrare anche nella cultura dei popoli barbari che si avvicendavano nel possesso e nel governo dei territori italiani e delle altre regioni europee, un tempo province romane; ad eccezione della penisola iberica che per ottocento anni fu dominata dalla civiltà islamica.
Quindi, fin dal primo medioevo, il pensiero filosofico cristiano si manifestò principalmente condizionato da quello imposto dalla Chiesa, in tutte le sfaccettature della sua cultura e dei comportamenti consentiti, relegando la conoscenza di ciò che del mondo classico era stato salvato dalla distruzione delle sua vestigia e dallo scempio delle biblioteche, nel chiuso dei monasteri, lasciandone uscire i contenuti, quando necessario, solo filtrati attraverso la sua interpretazione.
Così fu anche per la medicina. Ciò che era sopravvissuto degli studi dei grandi medici razionali del passato fu quasi completamente sostituito da una concezione di vita fatalistica e fideistica che fondava sull’idea del peccato, del destino, dei segni astrali e dell’immanente volontà divina le cure da applicare alle malattie, per cui i “rimedia phisicalia” (le terapie empiriche) erano per importanza subordinati agli interventi spirituali di penitenza, di rassegnazione alla volontà divina e accettazione del dolore e dell’infermità come meritata punizione e rimedio dei peccati commessi dall’individuo o dalla collettività.
Anzi, il concetto che i mali del mondo fossero una punizione inviata da Dio per i peccati commessi, aveva determinato una certa ostilità nei confronti delle terapie mediche, perché considerate una ribellione alla volontà divina in quanto la malattia doveva essere curata solo con la sofferenza e il pentimento. Pertanto, anche nei confronti dei medici si era sviluppata una sorta di pregiudizio, per cui la professione della medicina aveva finito con l’essere reputata indegna di un vero cristiano: il quale, invece, doveva umilmente accettare la sua “ meritata” punizione e ravvedersi, o accettare il dolore come penitenza affinché altri si ravvedessero. Le guarigioni, di conseguenza, erano ritenute una miracolosa, benevola manifestazione della Grazia Divina.
Anima e corpo erano creduti un unicum inscindibile. Quindi la malattia era considerata una forma di squilibrio dell’armonia tra queste due componenti. Tuttavia, la necessità di dare ai valori dell’anima la prevalenza rispetto alle esigenze del corpo aveva portato, come conseguenza, che il corpo ne fosse considerato solo un’appendice, disprezzata per le sue pulsioni così concrete e capaci di portare al peccato. Anzi, si era giunti a fare, delle diverse proporzioni nella distribuzione di questi due elementi nell’essere umano, la fondamentale differenza della natura tra i due sessi
(Sant’ Agostino). Infatti mentre l’equilibrio tra anima e corpo per l’uomo era perfetto in quanto all’uomo veniva attribuito il completo dominio del corpo attraverso la sua “ratio”, alla donna veniva riconosciuta una proporzione minore di “ratio” rispetto alle pulsioni del corpo. Ciò la portava ad una maggiore tendenza a seguirne gli impulsi e ad una minore capacità di resistere alle tentazioni. E con questa dogmatica argomentazione, affermata dalla indiscutibile parola di un Padre della Chiesa, veniva giustificato il disprezzo e la paura per tutto ciò che accompagnava le manifestazioni della femminilità: la donna, perciò, viveva tollerata solo per la sua insostituibile funzione riproduttiva, ma per il resto doveva essere tenuta a bada e completamente asservita all’uomo. Ciò comportava per la donna, sin dalla sua nascita, gravi conseguenze sulle sue condizioni di vita. Quindi, anche nel campo della medicina, delle cure, dell’alimentazione e dell’interesse alla sua salute in genere, nella società e nella sua stessa famiglia, a qualunque età e in qualunque stato si trovasse, non le si riconosceva il diritto di ricevere le stesse attenzioni e lo stesso rispetto che invece era considerato doveroso attribuire alle esigenze maschili.
Un principio essenziale del cristianesimo, però, è la carità: e la pietà verso il prossimo sofferente giustificava l’eventuale sollievo che si riusciva ad offrirgli. Proprio per questo, molti ordini monastici fecero della cura dei malati la loro principale attività.
Del resto i testi di Ippocrate, Galeno e degli altri medici dell’antichità, che erano stati salvati dalla distruzione delle biblioteche, erano finiti nei conventi dove venivano ricopiati e dove era possibile coltivare lo studio della lingua latina, ormai sconosciuta ai più. Pertanto, gli unici che potevano conoscere le teorie della medicina razionale contenute in quegli scritti e avere l’occasione di applicarle erano gli uomini della Chiesa, naturalmente adattandole ai principi imposti dalla loro visione del cristianesimo.
Per tutto il medioevo, perciò, non esistettero medici di professione, nè scuole e le poche conoscenze mediche venivano trasmesse da persona a persona, da padre in figlio, o nei conventi studiando per proprio conto, laddove possibile, gli antichi testi: la cura dei malati tornò ad essere un’attività svolta in ambito domestico o al massimo per i problemi più difficili, rivolgendosi a persone eventualmente presenti nella collettività che, in cambio di danaro, potevano essere ritenute in grado di risolverli, come qualche raro medico che, appunto, poteva riferirsi ai suoi occasionali studi di testi antichi, levatrici, cavadenti, conciaossa, praticoni, ciarlatani o persone con qualche conoscenza del potere delle erbe e dei minerali. I limiti tra la sapienza medica e gli altri rimedi erano molto confusi, per cui ad eseguire le terapie poteva essere chiunque, sulla base del suo personale ascendente presso la comunità: sacerdoti, astrologi, mistici, streghe, ecc..
Comunque, l’attività terapeutica si differenziava a seconda che fosse svolta in campagna o nei conventi. Infatti, la medicina delle campagne aveva un carattere principalmente basato su pratiche magiche, antichi riti e atteggiamenti cultuali che affondavano le proprie radici su credenze pagane, ancora vitali, malgrado l’attento e intollerante controllo della Chiesa, la quale le considerava un gravissimo ricorso ai poteri del demonio e degne di condanna per stregoneria.
La medicina dei conventi, invece, trovava la sua giustificazione nei principi della carità cristiana e a questa si uniformava. Sempre giustificati dal dovere della carità, in questo periodo furono creati nei conventi spazi per il ricovero di persone sole e bisognose di ogni tipo di assistenza, quali: vecchi, poveri, pellegrini, bambini abbandonati, malati ecc..
Successivamente, l’accoglienza di studiosi nei monasteri, che avessero anche voluto rendersi utili ed esercitare caritatevolmente le loro conoscenze mediche ai malati bisognosi, portò a creare strutture dove poter applicare anche le necessarie terapie. Nacquero così, sempre nell’ambito delle attività conventuali, le prime infermerie, i primi ospedali, campi di coltivazione, laboratori di raccolta, studio e trasformazione di erbe medicinali.
Una buona parte dei conventi in Europa, quindi, si dotò di tutte queste strutture per destinarle anche alla cura di malati secolari.
Comunque, il sapere scientifico ( sempre condizionato, spiegato e applicato attraverso l’interpretazione della filosofia cristiana) veniva trattato mescolato e integrato, senza distinzione, anche con altre discipline. Si possono, in proposito fare alcuni nomi di studiosi, quali: Boezio, Cassiodoro, Isidoro di Siviglia, Fulberto di Chartres, Einsiedeln, Canterbury e altri.
Il medioevo fu una terribile epoca in cui la popolazione europea, principalmente per la totale assenza di igiene e a causa dei contatti violenti dovuti alle guerre, fu falcidiata anche da malattie endemiche e pestilenze, tra cui si possono ricordare: la lebbra; la peste bubbonica del 543 (epoca di Giustiniano); la peste colica del VII secolo, probabile poliomielite; l’ergotismo del 550, dell’857 e di Parigi del 944 che, dovuti a ingestione di segala cornuta contenuta nella farina, fu vissuta come malattia contagiosa, anche se non lo era, a causa della sua enorme diffusione; e la peste nera, durata quattro anni nel tardo medioevo (1347-1351), che ridusse di circa un terzo l’intera popolazione europea.
Furono eventi epocali che colpirono pesantemente le popolazioni e furono da queste ovviamente accettati e giustificati come una maledizione e punizione divina per i peccati del mondo.
La teoria di base della medicina medioevale era quella dei quattro umori. Tale teoria derivava da opere di antichi medici e restò valida almeno fino al XIX secolo. Essa sosteneva che nel corpo dell’essere umano esistono quattro fluidi principali (umori): la bile nera, quella gialla, la flegma e il sangue. La buona salute derivava dall’equilibrio esistente nel corpo tra questi umori: la prevalenza o la carenza di ciascuno o di alcuni rispetto agli altri era causa di malattie che venivano curate con la dieta, le erbe e i salassi effettuati mediante l’applicazione di sanguisughe.
La diversa combinazione di questi umori nel corpo e i segni astrali di ciascun individuo, inoltre, erano presi in considerazione quali elementi determinanti della sua personalità e del suo carattere: e le terapie dovevano tenerne conto.
Tuttavia, nel dodicesimo secolo qualcosa cominciò a cambiare: furono tradotti e resi noti alcuni testi della medicina araba, tra cui il “Canone di medicina” dello scienziato Avicenna, che aveva raccolto il sapere medico dei greci, degli indiani e degli islamici. Questo Canone acquisì subito grandissima autorità ed ebbe anche il merito di sostenere la necessità di una rivalutazione delle funzioni del corpo e di favorire un maggiore rispetto per le sue esigenze e le sue sensibilità.
Inoltre, sempre nel XII secolo, nacquero le prime scuole e le prime università di medicina.
La prosecuzione di questo argomento alla prossima puntata.
Dott.ssa Silvana Vitali per Redazione VediamociChiara
© riproduzione riservata
…
Tempo di lettura: 4 minuti

 La medicina nel medioevo
La medicina nel medioevo